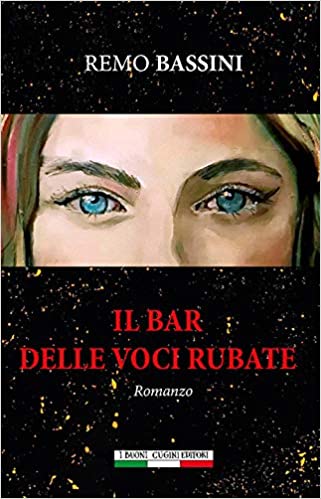alcuni passi de La suora, dove c’è Orta (il luogo del Piemonte che più amo…)
Orta San Giulio, dieci anni fa, una sera di gennaio. Saranno state le dieci, o le undici, che importa? Nelle sere sbagliate il tempo conta poco. Ero davanti all’ingresso dell’albergo dove avrei pernottato, non avevo voglia né di camminare né di salire in camera né di essere altrove.
(…)
E poi successe che, senza dire una parola, ci ritrovammo a camminare, piazza Motta, l’antico Broletto, via Olina, poi indietro, ancora in piazza Motta, i portici e le ultime finestre illuminate che, presto, avrebbero ceduto alla notte.
«Chissà quante storie ci sono nascoste là dentro» disse Nora, indicandomi il vecchio, imponente Albergo Orta, chiuso da anni.
Vedendomi sovrappensiero aggiunse «Lei ha un peso dentro».
(…)
…. all’isola di San Giulio il tempo viaggia su altri binari, perché il tempo, lì, è un tempo diverso. Forse più vero, perché si cura poco di orologi e calendari. È il tempo dell’anima, vien da pensare.
(…)
Nora era a Orta per un motivo preciso, io no; ero a Orta perché conosco bene i volti di questo borgo che profuma d’antico: nei giorni caldi della primavera e dell’estate Orta è un’esplosione di colori e di voci, ma nelle sere di freddo e nebbia è triste, senza vita. Era questo il volto che a me interessava. Il silenzio interrotto dal rumore dei miei passi e dallo sciabordio delle acque del lago.
(…)
So tutto, però, sulle suore benedettine che scelgono la clausura nel monastero Mater Ecclesiae a Orta San Giulio.
Loro dicono d’essere vicino a Dio, vivono nel silenzio e nella preghiera, ma vivono da recluse. Escono solo se stano male e devono essere ricoverate in ospedale, oppure se muore un loro parente. Oppure per votare. Escono l’ultima volta quando muoiono. Alle persone che amano spiegano che non è importante vedersi, sentirsi, parlare. Si svegliano prima delle quattro e, mentre il mondo sta ancora dormendo, assistono e pregano alla prima messa. Niente televisione, niente radio, niente internet. Vivono osservando la regola benedettina, Ora et labora, nel silenzio. Nell’isolamento più totale. Solo qualche giornale cattolico da sfogliare la sera, dopo la cena e dopo l’ultima preghiera, la Compieta. Poi la notte, in una minuscola cella.
(…)
Poi a Milano sono riconoscente. Le fughe nei fine settimana mi avevano fatto scoprire il lago d’Orta. Ero curioso di vedere i luoghi descritti da Gianni Rodari in “C’era due volte il barone Lamberto” o da Ernesto Ragazzoni, un poeta maledetto e dissacrante, nato proprio a Orta. Avevo conquistato i miei studenti, leggendo la poesia che scrisse quando fu inaugurato un cesso pubblico.
Lodate dunque, culi d’Orta, i cieli!
Cularelli innocenti degli asili,
immensi tafanari irti di peli…
(…)
Adesso, sto ascoltando l’acqua che s’infrange sul motoscafo che mi sta portando all’isola. Ecco, sono arrivato. Non so ancora cosa ti racconterò.
Ma so che ho qualcosa da dirti, ancora.
PS. L’albergo che cito all’inizio è il Leon d’oro. Lo stesso in cui soggiornò Dostoevskij
Nel caso: questo è il primo capitolo