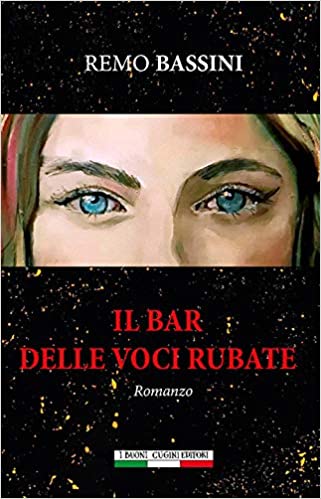Bella recensione di un libro da leggere.
La morte di Auguste
Georges Simenon
Traduzione di Laura Frausin Guarino
Romanzo
Adelphi Milano
2025
Pag. 157 euro 18
Valerio Calzolaio
Parigi, Le Halles. Marzo 1966. Muore a quasi 79 anni Auguste-Victor-André Mature, accasciandosi per un ictus nel suo piccolo splendido bistrot di rue de la Grande-Truanderie, Chez l’Auvergnat, prosciutti e salami appesi in vetrina, bancone di stagno e tavoli di marmo. Lo aveva rilevato nel 1913, con i suoi risparmi e un po’ di soldi che il fratello gli aveva prestato, senza immaginare che l’anno dopo lo avrebbero spedito al fronte. Lentamente poi ne aveva fatto un locale eccellente e rinomato, amato anche da clientela importante (ministri, ambasciatori), due stelle Michelin. Diciassette anni fa aveva coinvolto alla pari nella gestione il secondo dei suoi tre figli, Antoine, ora quasi 50enne, restato a lavorare con lui e la moglie fin dall’inizio, mentre il primo figlio Ferdinand (tre anni più grande) diventava un solerte dedito magistrato e il terzo Bernard (tre anni più piccolo) un avventuroso debosciato semialcolizzato. La morte di Auguste scatena fame di eredità nei fratelli. Antoine è felicemente sposato con una ex prostituta, sensibile attenta silenziosa, lei (con una malattia venerea) non poteva aver figli, hanno condiviso amore e fatica. I fratelli non si sono mai molto fatti vedere al ristorante (il minore solo per chiedere soldi), hanno delegato sia l’affetto per il padre, originario di Riom nella regione dell’Alvernia-Rodano-Alpi, arrivato a Parigi senza un soldo in tasca, sempre restato “contadino” dentro, sia l’assistenza ai genitori che invecchiavano e arrancavano progressivamente (la madre ormai è da tempo poco presente alla vita). Ferdinand ha una bella ambiziosa arcigna moglie, Véronique, e due figli già grandicelli e ormai autonomi. Bernard ora sta con la 28enne Nicole, graziosa elegante vivace, ex modella e indossatrice, cattiva. Il testamento non si trova, nemmeno denaro nascosto, solo una chiave nel portafoglio. Si scatenano attriti, risentimenti, menzogne. E non è un bel vedere.
Il romanzo è molto bello. Mesto angosciante avvilente, ma eccelso e struggente. Di Simenon sappiamo quasi tutto (1903 – 1989, origine bretone, belga di nascita, francese d’adozione, non solo parigino d’elezione, oltre trecento romanzi, uno degli autori più letti al mondo) e la grande casa editrice milanese Adelphi sta ottimamente progressivamente garantendo la pubblicazione integrale dei suoi scritti. Questa lunga ansiogena tragedia familiare, originariamente del 1966, né noir né rosa, era inedita in italiano. La narrazione è in terza varia al passato, prevalentemente su Antoine, sempre più disgustato dalla situazione che si viene a creare dopo la morte del padre cui era legatissimo (da cui il titolo): “si capivano. Avevano lo stesso genere di vita, lo stesso modo di pensare, vivevano in mezzo allo stesso tipo di persone”. Un ruolo decisivo di coprotagonista è svolto in tante pagine liricamente descrittive dal quartiere dove Auguste e il figlio hanno avuto consolidato successo enogastronomico, le strade e la gente, le botteghe mitiche e i mercati antichi; siamo quasi alla vigilia dello “sventramento” del 1971 e già si annunciano progetti, ristrutturazioni e delocalizzazioni; una seconda morte nel romanzo, non attuale ma “annunciata”, anche adesso restituendoci mirabilmente la Parigi che qualcuno di noi conobbe “prima” e oggi ritrova solo nei libri di storia e fotografia: “nel giro di pochi anni Le Halles sarebbero sparite, i padiglioni smontati come giocattoli”. Il vino che accompagna spesso i pasti è vario e mai ordinario: Gamay d’Auvergne, Chanturgue, bianco rosé di Corent o di Sauvagnat; poi acquavite o armagnac. Molto in sottofondo il necessario accompagnamento musicale da funerale.