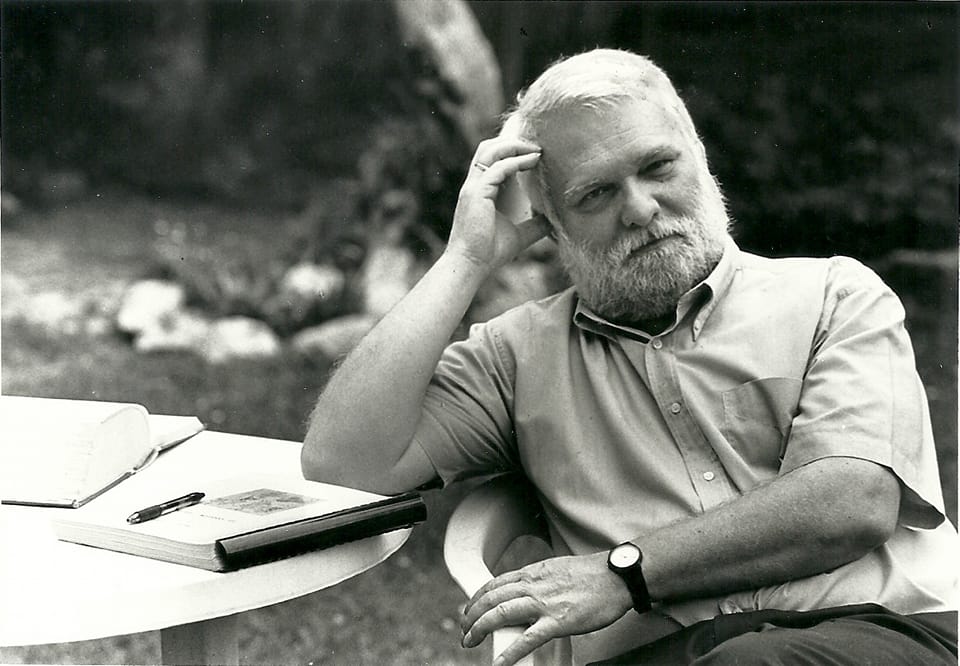Le ossessioni non sono mai belle, eccetto Nora.
Orta San Giulio, dieci anni fa, una sera di gennaio. Saranno state le dieci, o le undici, che importa? Nelle sere sbagliate il tempo conta poco. Ero davanti all’ingresso dell’albergo dove avrei pernottato, non avevo voglia né di camminare né di salire in camera né di essere altrove.
Risposi con un cenno della testa al suo saluto, mentre mi passava accanto per entrare al Leon d’oro. Prima che la porta si richiudesse alle sue spalle, sgusciai dentro anche io, ma non era mia intenzione seguirla: non ero alla ricerca di nessuna donna, di nessun incontro. Alla ragazza assonnata della reception, Nora domandò la chiave della sua stanza, io una bottiglia di acqua minerale, per poi uscire di nuovo.
Appena fuori, mi accorsi che non ero solo.
Disse «Niente, questa sera il sonno non vuole arrivare».
I tuoi occhi, Nora, vedevano oltre.
La guardai senza voglia di guardarla. Protetto da una cuffia gialla, un viso sottile, che dava l’impressione del già visto: non brutto, ma insignificante; indossava una gonna pudica, sotto il ginocchio, un montgomery a quadrettoni verdi e blu, degli scarponcini.
Le sue caviglie erano nascoste, quindi. Le caviglie di una donna – è una mia fissa – sono rivelatrici. È anche un gioco tutto mio per passare il tempo, anni fa in metropolitana, oggi in qualche trattoria o bar: con lo sguardo ad altezza piedi, provo a indovinare se una sconosciuta ha – secondo i miei parametri – fascino o meno osservandole, appunto, le caviglie. Difficile che mi sbagli. Ma il ricordo delle sue caviglie nascoste venne dopo, quando cercai di ricostruire ogni momento, ogni minuto, insomma ogni cosa di lei.
Nora era a Orta per un motivo preciso, io no; ero a Orta perché conosco bene i volti di questo borgo che profuma d’antico: nei giorni caldi della primavera e dell’estate Orta è un’esplosione di colori e di voci, ma nelle sere di freddo e nebbia è triste, senza vita. Era questo il volto che a me interessava. Il silenzio interrotto dal rumore dei miei passi e dallo sciabordio delle acque del lago.
Ero fuggito da Milano, da un funerale, dalle parole e da tutti. Il cellulare l’avevo lasciato in camera, spento.
Li ho messi in fila e li ho ordinati, poi, i ricordi e i pensieri di quel lunedì sera, 25 gennaio del 2010.
Se cerchi compagnia per questa notte hai sbagliato persona, fu il primo pensiero, anche indigesto però, perché mi provocò un conato di vomito. Non avevo cenato: solo un’alternanza folle di caffè, birre, Campari.
«Lei non sta bene, rientriamo, dovrebbe bere qualcosa di caldo.»
Non le risposi, ma al suo sorriso risposi con un sorriso – era impossibile non essere contagiati dalla sua gentilezza, una gentilezza antica, vera, punto affettata. E poi successe che, senza dire una parola, ci ritrovammo a camminare, piazza Motta, l’antico Broletto, via Olina, poi indietro, ancora in piazza Motta, i portici e le ultime finestre illuminate che, presto, avrebbero ceduto alla notte.
«Chissà quante storie ci sono nascoste là dentro» disse Nora, indicandomi il vecchio, imponente Albergo Orta, chiuso da anni.
Vedendomi sovrappensiero aggiunse «Lei ha un peso dentro».
Non dissi nulla, non volevo dire nulla, stavo un po’ meglio, Milano però continuava a perseguitarmi.
Mezz’ora dopo, forse meno, nella mia testa c’era qualcosa di diverso: Stammi vicino e fammi compagnia tutta la notte. La sua voce, il suo sorriso e qualcosa d’altro – che ancora adesso non so spiegare – mi stavano conquistando. Avrei voluto dirle «mi trovo bene con te, ci diamo del tu?», ma non ne ebbi il tempo.
«Fa freddo, non trova? Sono anche un po’ stanca.»
Aveva ragione, era da un po’ che si scaldava con il fiato le punta delle dita, aveva ragione e glielo dissi. «Sì, rientriamo. Mi scusi, non mi ha detto il suo nome.»
«Nora.»
«Piacere, Romolo.»
Adesso non c’era più anima viva, tutto buio. Aveva ragione, certo, io indossavo solo una giacca, e la sciarpa che avevo al collo non mi avrebbe salvato dal mal di gola e dalla febbre nei giorni successivi, ma non so cosa avrei dato per continuare a provare quei brividi; mi angosciava l’idea di trovarmi, solo con me stesso, in camera d’albergo.
Mentre camminavamo verso il Leone d’oro la mia mano destra cercava di incontrare e quindi sfiorare la sua mano sinistra, ma non accadde. Quando mi dirai buonanotte mi sentirò perduto, fu il terzo pensiero.
Non volevo che la notte me la portasse via. Annetta continuava a seguirmi come un’ombra, era giusto così, era giusto che non se ne andasse. Ma nemmeno Nora doveva. Arrivò il quarto pensiero. Voglio dormire con te.
Rientrammo al Leon d’oro, e mentre salivamo le scale dell’albergo quasi smaniavo affinché quel pensiero, Voglio dormire con te, diventasse parola. Diventasse la notte che non pensavi.
Il ricordo di quel che accadde, poi, è ancor più vivido, come lo sono certi ricordi insistenti, che tornano sempre.
La rivedo, si dirige verso la sua stanza, che è poco distante dalla mia, la seguo ma quando mi dice «Buonanotte Romolo, è stato un piacere conoscerti» mi blocco: sono di pietra. Mi hai dato del tu, bene, mi fa piacere, però aspetta, che ho qualcosa a dirti. La vedo che entra nella sua stanza, ma invece di chiudere completamente la porta si gira verso di me; metà del suo corpo è dentro, l’altra metà – è chiaro – mi sta aspettando. Penso: ci sta. Penso che è arrivato il momento di dirle “Voglio dormire con te”. E invece commetto un errore. Dico a me stesso: No, meglio aspettare qualche minuto. Intanto mi avvicino e parlo, parlo, va bene tutto quello che mi viene in testa, dal riscaldamento che mi sembrava eccessivo alla voglia matta che avevo di un caffè, «Ne sono un bevitore compulsivo, e tu?». Parlo sottovoce per non disturbare la ragazza assonnata della reception, Nora mi osserva. Non può che essere interdetta: prima non dicevo nulla, adesso sparo una cazzata dopo l’altra.
Sono teso, vorrei fumare ma temo di darle fastidio. Una parte di me spera che mi inviti a entrare, l’altra teme un saluto e che la sua porta si chiuda.
Mi viene in soccorso un pensiero diabolico. Dell’impostore che è in me. Adesso le racconto del suicidio di Annetta, così mi consolerà, così parleremo ancora e poi ancora. Non avrei dovuto.
«Sei impallidito, non stai bene?»
“Faccio schifo, non puoi sapere quanto” sono tentato di risponderle. Ho voglia di piangere, vorrei dirle tutto, stavolta senza secondi fini.
Vorrei raccontarle che Annetta si è uccisa due giorni fa. Poche ore prima di impiccarsi mi aveva inviato un sms: ‘Ehi prof, non li trovi dieci minuti per parlare con me?’ Non li avevo trovati. Eppure, lo sapevo che Annetta stava vivendo giorni terribili. Suo padre aveva un’altra donna, e lei non riusciva ad accettarlo.
No, non devo dirle di Annetta, pensai. Smetto di sproloquiare. La mia mente, adesso, rivedeva quel messaggio a cui avrei dovuto rispondere. Annetta stravedeva per me. Mi viene in mente mamma: ci resterà male quando le dirò che abbandono l’insegnamento. Ora però dovevo tornare a Nora, rassicurarla, sedurla. «No, sto bene, se tu parli sto bene. Parlami di te, ti prego.»
Mi sorride. «Ma non ho nulla di interessante da raccontare.»
«Ti prego, parti da lontano lontano, dimmi dei tuoi anni all’asilo, della tua bambola preferita…»
Parla, che poi ho qualcosa da dirti.
Per evitare di ridere, si porta una mano davanti alla bocca e spalanca gli occhi. Che non sono gli occhi di una donna insignificante, penso. «Allora, vediamo…» dice, sussurrando.
«Non amavo le bambole, ma adoravo i carillon, senza la musica del carillon che papà comprò quando nacqui non mi addormentavo. E poi, non so cosa raccontarti, la mia vita non è interessante… Sono nata a Cuneo, ma ci credi che la conosco poco? Non mi piace passeggiare, andare in giro, frequentare persone. Al Liceo ero un orso…»
«Ma qualche volta sarai andata in Piazza Galimberti, avrai mangiato un gelato.»
«Conosci Cuneo? Mah sì, mi piacciono i gelati, menta e nocciola sono i gusti che preferisco, però vedi…»
Tutta casa e chiesa e qualche gelato, allora.
«Il mio mondo era ed è la mia casa, il mio giardino, i miei cani. I miei libri… E poi… fammi pensare. Quando ero bambina, la domenica ci svegliavamo presto, andavamo in giro per le Langhe. Papà le adorava, andavamo sempre dalla stessa famiglia di produttori di vino che ci riforniva di Dolcetto. Chissà se sono ancora vivi… Come vedi ho poco da raccontarti. Ci credi che non sono andata mai all’estero?»
«Nemmeno una gita quando frequentavi il Liceo?»
«Solo una volta, a Firenze, ma all’estero mai, non mi andava. È grave?»
Sorride. Parla volentieri. Bene. Mi racconta che dopo essersi laureata in veterinaria a Torino, per un po’ di tempo ha lavorato nel laboratorio di una sua amica a Pinerolo.
«Poi papà si ammalò, gravemente. Gli avevano dato un anno di vita, ne ha vissuti ancora sei, ed è morto in casa, come desiderava, con me e mamma accanto. Dovevamo restituirgli tutto l’amore che ci aveva donato. Durante la malattia, papà ci invitava a uscire, e un po’ lo abbiamo accontentato. Io ho fatto del volontariato in un canile, mi rendevo utile come veterinaria, mia madre invece dava una mano in una casa di riposo. Vedi Romolo, eravamo una famiglia benestante, ma credimi, anche se fossimo stati poverissimi io e mia madre avremmo fatto di tutto per stargli accanto.»
L’ascolto e penso: hai solo un piccolo mondo che gravita attorno a tua madre Camilla e al ricordo di tuo papà? Non è possibile.
Lei, intanto, sta continuando a parlare. Non sbadiglia, nessun cenno di stanchezza.
Si è tolta solo la cuffia, fa caldo adesso. Che belli i tuoi capelli un po’ mossi, che bello il tuo viso senza trucco…
«Però non va bene Romolo, adesso dimmi di te… no, se hai un peso e non ne vuoi parlare mi sta bene, ma… non so dove vivi, non so che lavoro fai, non so niente di te.»
«Sono pugliese, non ho moglie, figli, vivo a Milano, insegno in una scuola, o meglio insegnavo… Ma questo è un tasto dolente. Nei prossimi giorni mi trasferirò in Valsesia, conosci la Valsesia? Varallo, il Monte Rosa, la storia del popolo Walser, hai mai sentito parlare dei Walser?»
«Perché ti piace così tanto la Valsesia?» mi aveva chiesto Annetta.
«Forse perché mi piace la neve.»
«A me invece piace la primavera, a te no?»
«Amo la primavera e non vedo l’ora che arrivi, così come amo i giorni e le notti insonni di gran caldo d’agosto. Ma la neve, la neve di notte, la neve al risveglio, la neve sui tetti, sugli alberi… la neve insomma ha un fascino tutto suo, solo suo, unico… capisci Annetta?»
«Capisci Nora?»
«Capisco… ma tu… tu da cosa stai fuggendo? Scusa, non volevo…»
«Hai ragione Nora, sto fuggendo e voglio cominciare un’altra vita.»
«Anche tu?»
Quell’“Anche tu?” aveva un significato preciso, ma io, sbadato, non ci feci caso.
«Ah, dimenticavo; ho trentasei anni» dico. Mi sento in graticola: non voglio parlarle di me, parlare di me significava pensare a Milano e ad Annetta.
«Ma pensa, sono più vecchia di te.»
Scopro che dietro a quel visino da ragazzina c’è una donna: Nora ha appena compiuto trentasette anni, ha nove mesi più di me.
«Te ne davo ventotto, massimo ventinove…» le dico, e sono sincero.
Arrivò il quinto e ultimo pensiero: adesso ti bacio.
«Anche io sto per cambiare vita» sussurra, abbassando gli occhi. Ma poi la rialza. Il suo viso, adesso, è un volto fiero.
«Tra un mese diventerò una suora dell’ordine benedettino. Andrò a vivere nel monastero dell’isola di San Giulio.»
Mi manca il fiato, «Ah, ho capito» dico. Poi devo avere aggiunto altro, parole inutili che non mi importa di ricordare.
«Ah ho capito» è l’ultima frase di un film con un finale che non ti aspetti.
Quando mi stesi sul letto erano quasi le due. Annetta, adesso, era un pensiero che si era fatto da parte, in un angolo della stanza, silenzioso. Al posto suo c’erano Nora e una frase non detta.
Non riuscii a prendere sonno, guardavo la porta. Nora era così vicina. Mi alzai, uscii dalla stanza e mi diressi verso la sua. Non bussai, rimasi lì per un po’, indeciso.
La sveglio con un colpo di tosse, con un urlo?
Avrei voluto, invece tornai nella mia camera, sconfitto.
La suora su Amazon